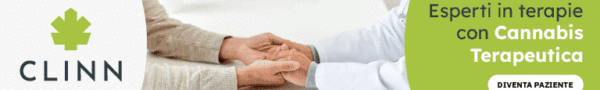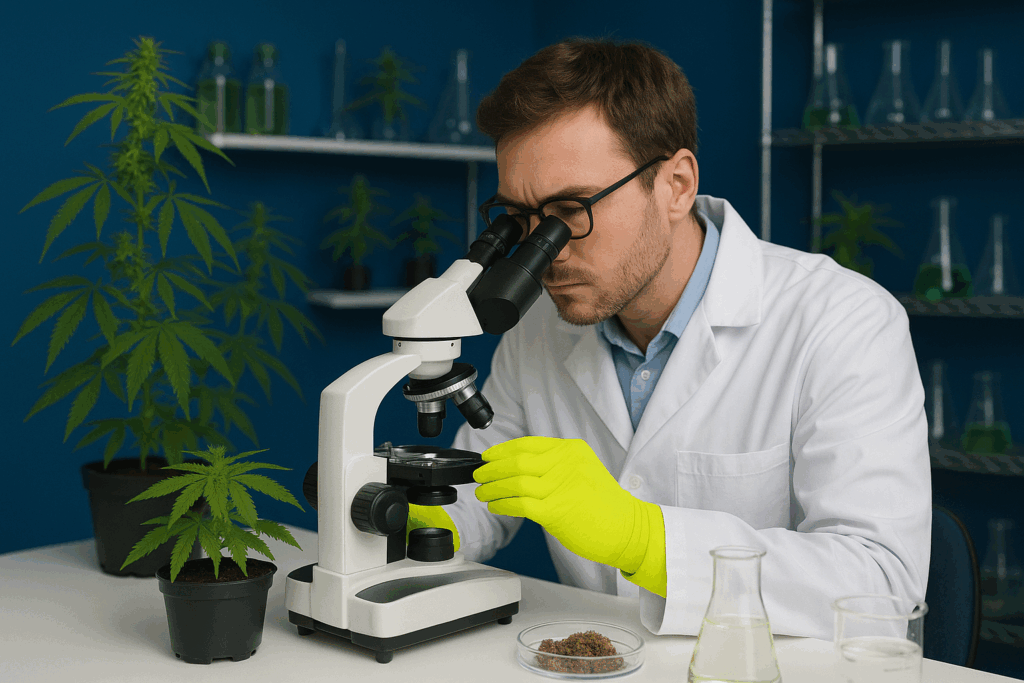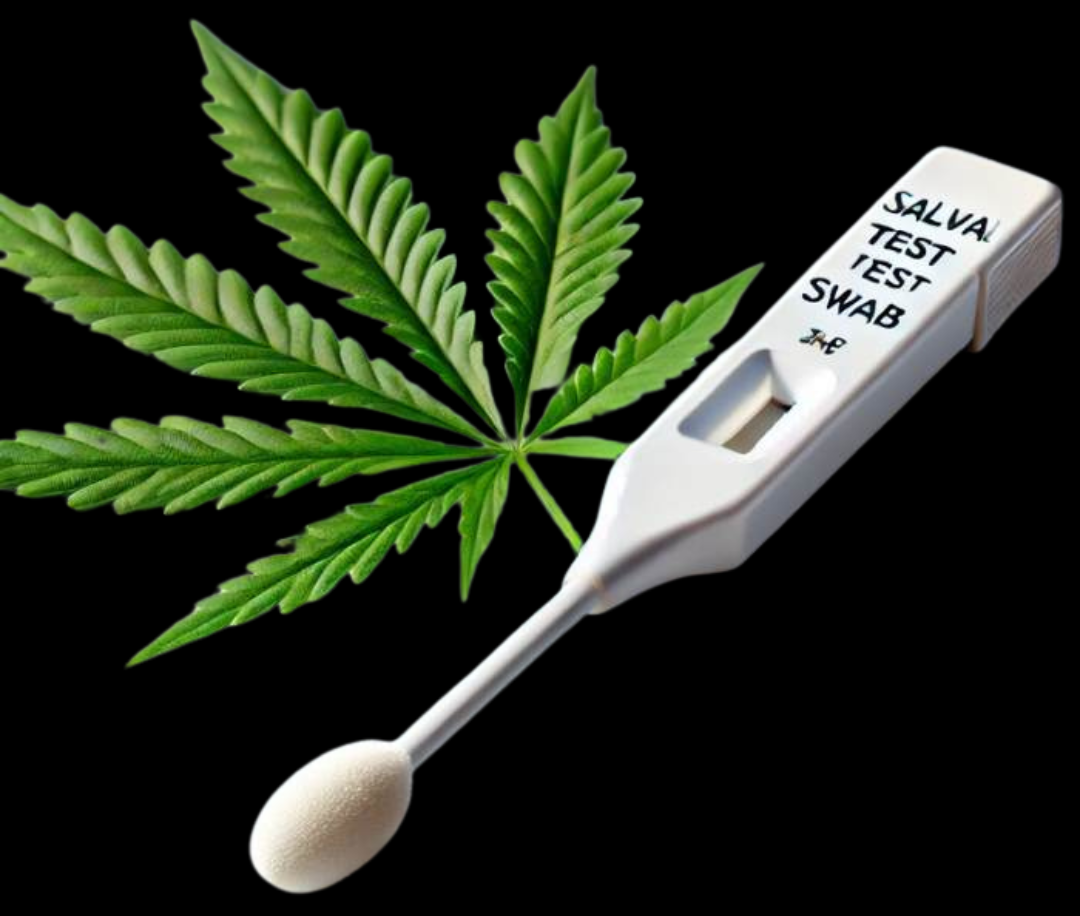Un importante cambio di rotta arriva dal Ministero della Salute e da quello dell’Interno in merito agli accertamenti per l’uso di droghe alla guida. Con una nuova direttiva emanata l’11 aprile, i due dicasteri chiariscono che, per configurare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non basta più un semplice test positivo: bisogna dimostrare che la droga sia stata assunta di recente e che stia ancora influenzando le capacità del conducente.
Questo aggiornamento, che si innesta nel più ampio contesto del nuovo Codice della Strada, rappresenta un parziale ritorno al passato. Prima delle modifiche normative, infatti, era necessario che il conducente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica per essere sanzionato. Con la riforma, era invece sufficiente una positività al test, anche se le sostanze erano state assunte giorni prima e non incidevano più sulla lucidità di guida.
Le critiche non si erano fatte attendere: medici e giuristi avevano sollevato preoccupazioni sull’attendibilità dei test salivari, capaci di rilevare tracce anche molto tempo dopo l’assunzione, o di confondere farmaci legali – come quelli a base di codeina o il comune ibuprofene – con droghe vietate.
Proprio su questi presupposti si è mossa la Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sulla legittimità della norma dopo il caso di una donna positiva agli oppiacei per l’assunzione di un farmaco prescritto.
Ora, con la nuova circolare, l’orientamento cambia: per dimostrare la guida sotto effetto di droghe servono analisi ematiche o di saliva che certifichino un’assunzione recente e una reale alterazione. Non basta più il semplice riscontro della sostanza nel corpo, ma bisogna provare che essa sia ancora attiva e in grado di compromettere la sicurezza stradale.
Questa mossa sembra voler sanare almeno in parte i dubbi e le incongruenze emerse con la riforma, in attesa che anche la Corte costituzionale faccia chiarezza una volta per tutte.
Precisiamo che la direttiva in questione non ha alcuna valenza di legge, ma risulta un passo avanti verso una modifica definitiva del Nuovo Codice della Strada.