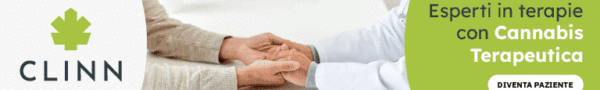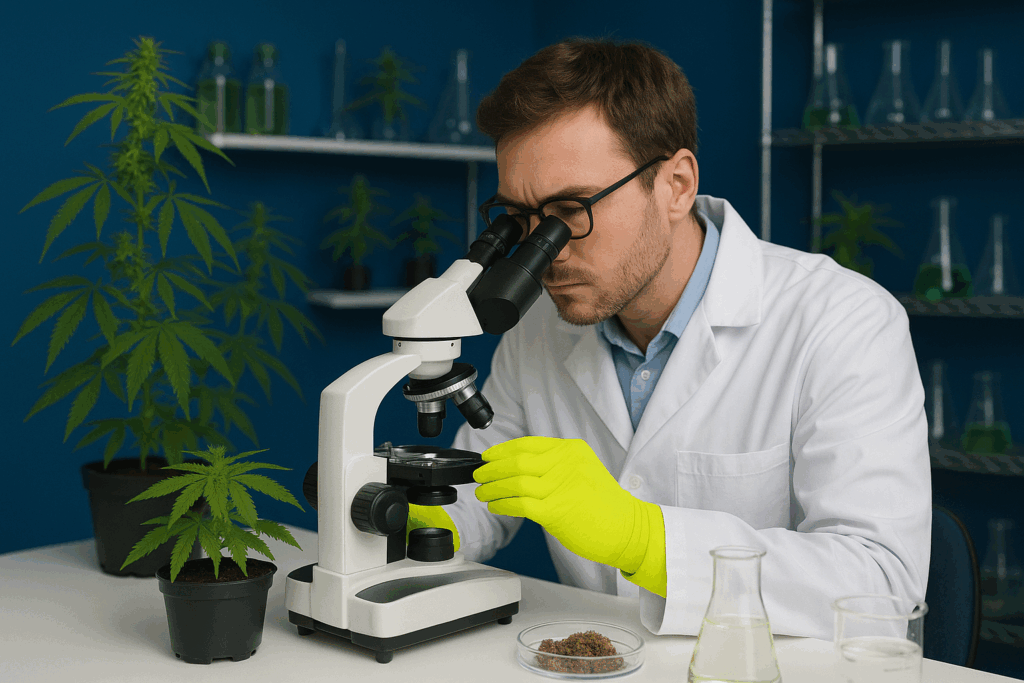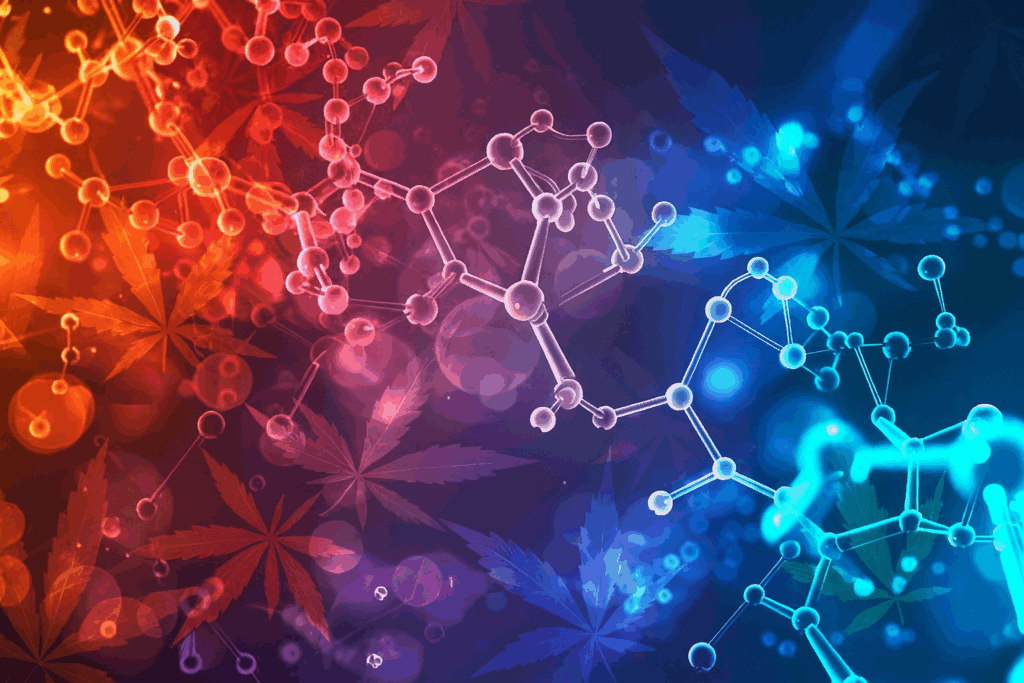I numeri, si sa, in politica sono spesso utilizzati come strumenti narrativi. Servono a costruire un racconto di successo, a legittimare una riforma, a mostrare risultati immediati. Ma raramente vengono presentati nel loro contesto completo, con le necessarie cautele e i limiti che ogni statistica porta con sé. È quello che è accaduto di recente con le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sul nuovo Codice della Strada.
I dati sugli incidenti stradali
«Nuovo Codice della strada in vigore da 7 mesi, meno 81 morti, meno 958 feriti, meno 1034 incidenti stradali, meno 15% di multe. Questo vuol dire che la prudenza e il buonsenso al volante stanno premiando. Insieme si vince e si vive».
Le parole del ministro sono chiare e rassicuranti. I numeri citati corrispondono a quelli diffusi ufficialmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e segnalano un calo negli incidenti stradali. Tuttavia, tutti i report ufficiali sottolineano che si tratta di risultati preliminari, parziali e riferiti a soli sette mesi.
Per comprendere davvero l’efficacia delle nuove norme serviranno: confronti annuali completi, che tengano conto della stagionalità e delle variazioni fisiologiche nei flussi di traffico; dati provenienti anche dalle polizie locali, che rappresentano una quota significativa dei controlli e delle rilevazioni; un’analisi di lungo periodo, capace di distinguere l’effetto delle nuove regole da altri fattori (condizioni meteo, campagne di sensibilizzazione, pandemia, ecc.).
Insomma, i dati non sono falsi, ma la loro presentazione è parziale e funzionale a un messaggio politico: il Codice della Strada funziona, e funziona subito.
La selettività sul tema cannabis
Quando però si parla di cannabis, Salvini adotta una strategia opposta. In questo caso, ignora o minimizza i dati scientifici disponibili, anche quando provengono da fonti prestigiose e consolidate.
Uno degli studi più recenti, condotto dai ricercatori dello Schmidt College of Medicine della Florida Atlantic University e pubblicato su Pediatric Reports, mette in luce due dati fondamentali sul consumo giovanile negli Stati Uniti: la percentuale di adolescenti che hanno dichiarato un uso attuale di marijuana è scesa dal 23,1% nel 2011 al 15,8% nel 2021; anche chi affermava di aver provato la cannabis prima dei 13 anni è calato dall’8,1% al 4,9% nello stesso periodo.
Non si tratta di un’eccezione isolata. La American Medical Association ha pubblicato sul Journal of the American Medical Association (JAMA) un’analisi che ribadisce come la legalizzazione della cannabis, sia medica sia ricreativa, non abbia portato a un aumento del consumo tra i giovani. Al contrario, la regolamentazione dei mercati ha mostrato effetti di contenimento.
Già nel 2019, uno studio su JAMA Pediatrics realizzato con i dati del Youth Risk Behavior Survey (1993–2017) segnalava come le leggi sulla cannabis ricreativa fossero associate a: un calo dell’8% dei liceali che dichiaravano di aver usato marijuana negli ultimi 30 giorni; un calo del 9% di chi affermava di averla usata almeno 10 volte nello stesso arco temporale.
Due pesi, due misure
Il confronto tra i due atteggiamenti è emblematico. Sulla sicurezza stradale, Salvini enfatizza numeri parziali, ma immediatamente spendibili sul piano comunicativo. Sulla cannabis, preferisce non citare affatto i dati scientifici, perché non combaciano con la sua posizione proibizionista.
Questa dinamica è il cuore della comunicazione politica contemporanea: non si tratta di manipolare i dati, ma di sceglierli selettivamente. Alcuni diventano bandiere da sventolare, altri vengono ignorati perché rischiano di contraddire il messaggio ideologico.
L’esempio dei dati sul consumo giovanile è solo uno dei tanti numeri sistematicamente ignorati dalla politica quando non si allineano alla narrazione dominante. Gli argomenti a favore della legalizzazione della cannabis non si fermano lì: significherebbe sottrarre miliardi di euro ogni anno alle casse della criminalità organizzata, garantire prodotti sicuri e controllati per i consumatori, ridurre i rischi sanitari legati al mercato nero e, al tempo stesso, liberare risorse giudiziarie, sfollamento delle carceri (che in Italia vivono situazioni impietose in alcune città), e forze dell’ordine oggi impegnate nella repressione di reati minori. In altre parole, si tratta di una scelta che non riguarda solo la salute pubblica, ma anche la sicurezza, l’economia e la giustizia sociale.
Il nodo centrale non è se Salvini menta o meno — i numeri che cita sul Codice della Strada sono reali. La questione è l’uso politico della statistica: valorizzare i dati che rafforzano la propria narrazione, ignorare quelli che la mettono in discussione.
È un approccio che non riguarda solo Salvini, ma gran parte della classe politica: in un’epoca di comunicazione immediata, i numeri smettono di essere strumenti di analisi e diventano slogan.
Il rischio, però, è che i cittadini perdano la capacità di leggere i dati nella loro interezza, e che la politica finisca per decidere non in base alle evidenze, ma in base alla convenienza del momento.